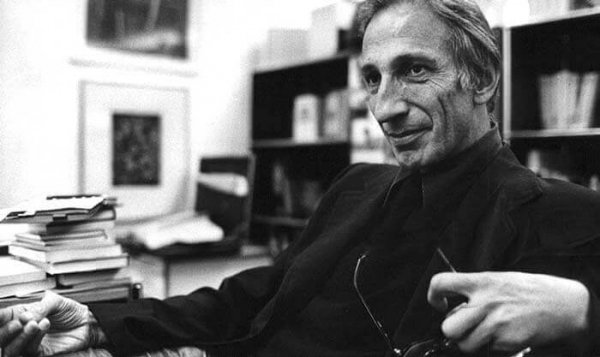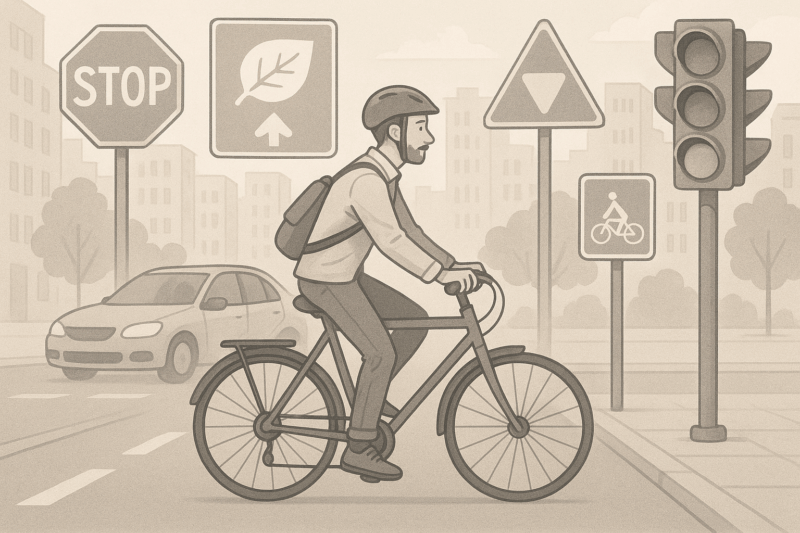Ivan Illich è stato un libero pensatore poliglotta. Nato a Vienna da padre croato e mamma austriaca, visse e studiò in Italia. Poi sarà a New York, Porto Rico e Messico, ancora in Italia e in Germania.
Nei sui libri “Tools for Conviviality” (tradotto in italiano nel 1974 con il titolo “Convivialità”) e “Energy, vitesse et justice sociale” (tradotto in italiano nel 1981 con il titolo “Elogio della bicicletta”) entrambi del 1973, Illich, critica fortemente il sistema industriale degli anni 70 che porta al consumo di energia e vita verso limiti controproducenti per l’uomo.
Tratto da “Convivialità”:
“I trasporti, per esempio, possono monopolizzare la circolazione. Le automobili possono modellare una città a loro immagine, eliminando praticamente la locomozione a piedi o in bicicletta, come a Los Angeles. La costruzione di strade per autobus può annullare la circolazione fluviale, come in Tailandia. Che l’automobile riduca il diritto di camminare, questo è monopolio radicale, e non il fatto che si contino più guidatori Fiat che Alfa Romeo. Che la gente sia obbligata a farsi trasportare e divenga incapace di circolare senza motore, questo è monopolio radicale”.
Sempre tratto da “convivialità”:
Finché si attaccherà il trust Ford per la sola ragione che arricchisce il signor Ford, si coltiverà l’illusione che le officine Ford potrebbero arricchire la collettività. Finché la popolazione penserà di poter trarre vantaggio dall’automobile, non rimprovererà a Ford di fabbricare auto. Fino a quando condividerà l’illusione che sia possibile aumentare la velocità di locomozione di chiunque, la società continuerà a criticare il proprio sistema politico anziché immaginare un sistema di circolazione moderno, più efficiente di tutti quelli che si basano su veicoli rapidi. La soluzione tuttavia è a portata di mano: non risiede in un certo modo di appropriazione dello strumento, ma nella scoperta del carattere di certi strumenti, e cioè che nessuno potrà mai possederli. Il concetto di appropriazione non vale per gli strumenti incontrollabili. Il problema urgente è invece di determinare quali strumenti possono essere controllati nell’interesse generale, e di comprendere che uno strumento non controllabile rappresenta una minaccia insostenibile. Quanto al sapere come organizzare la partecipazione individuale a un esercizio del controllo che risponda all’interesse generale, è un fatto secondario.
Certi strumenti sono sempre distruttivi, qualunque sia la mano che li governa: la mafia, i capitalisti, una ditta multinazionale, lo Stato o anche un collettivo di lavoratori. Così è per esempio, per le reti autostradali a corsie multiple…”
Tratto da “Elogio della bicletta”
Appena si arriva a dipendere dal trasporto, non solo per i viaggi che durano parecchi giorni ma per gli spostamenti quotidiani, diventano acutamente palesi le contraddizioni tra la giustizia sociale e la potenza motorizzata, tra il movimento efficace e l’altra velocità, tra la libertà personale e l’itinerario preordinato. La dipendenza forzata dalle macchine automobili nega allora a una collettività di persone semoventi proprio quei valori che i potenziati mezzi di trasporto dovrebbero in teoria garantire.
La gente di muove bene con le proprie gambe. Questo mezzo primitivo per spostarsi apparirà, a un’analisi appena attenta, assai efficace se si fa un confronto con al sorte di chi vive nelle città moderne o nelle campagne industrializzate. E riuscirà particolarmente suggestivo quando ci si renda conto che l’americano d’oggi, in media, percorre a piedi (per lo più in tunnel, corridoi, parcheggi e supermercati) tanti chilometri quanti ne percorrevano i suoi antenati.
Coloro che vanno a piedi sono più o meno uguali. Chi dipende esclusivamente dalle proprie gambe, si sposta secondo lo stimolo del momento, a una velocità media di 5 o 6 chilometri l’ora, in qualunque direzione per andare in qualsiasi posto che non gli sia legalmente o materialmente precluso. Ci si aspetterebbe che oggni miglioramento di tale mobilità connaturata prodotto da una nuova tecnologia del trasporto salvaguardi quei valori e ne aggiunga degli altri, come un maggior raggio d’azione, risparmio di tempo, comodità, maggiori possibilità per i menomati. Sinora non è questo che è accaduto. Anzi, lo sviluppo dell’industria del trasporto ha avuto dappertutto l’effetto opposto. Questa industria, da quando le macchina hanno potuto mettere dietro ogni passeggere più di un certo numero di cavalli vapore, ha diminuito l’eguaglianza fra gli uomini, ha vincolato la loro mobilità a una rete di percorsi disegnata con criteri industriali e ha creato una penuria di tempo d’una gravità senza precedenti. Appena la velocità dei loro veicoli varca una certa soglia, i cittadini diventano consumatori di trasporto nel giro dell’oca quotidiano che li riporta a casa, un circuito che gli uffici di statistica chiamano “spostamento” per distinguerlo dal vero “viaggio”che si ha quando il cittadino, uscendo di casa, si munisce di uno spazzolino da denti.